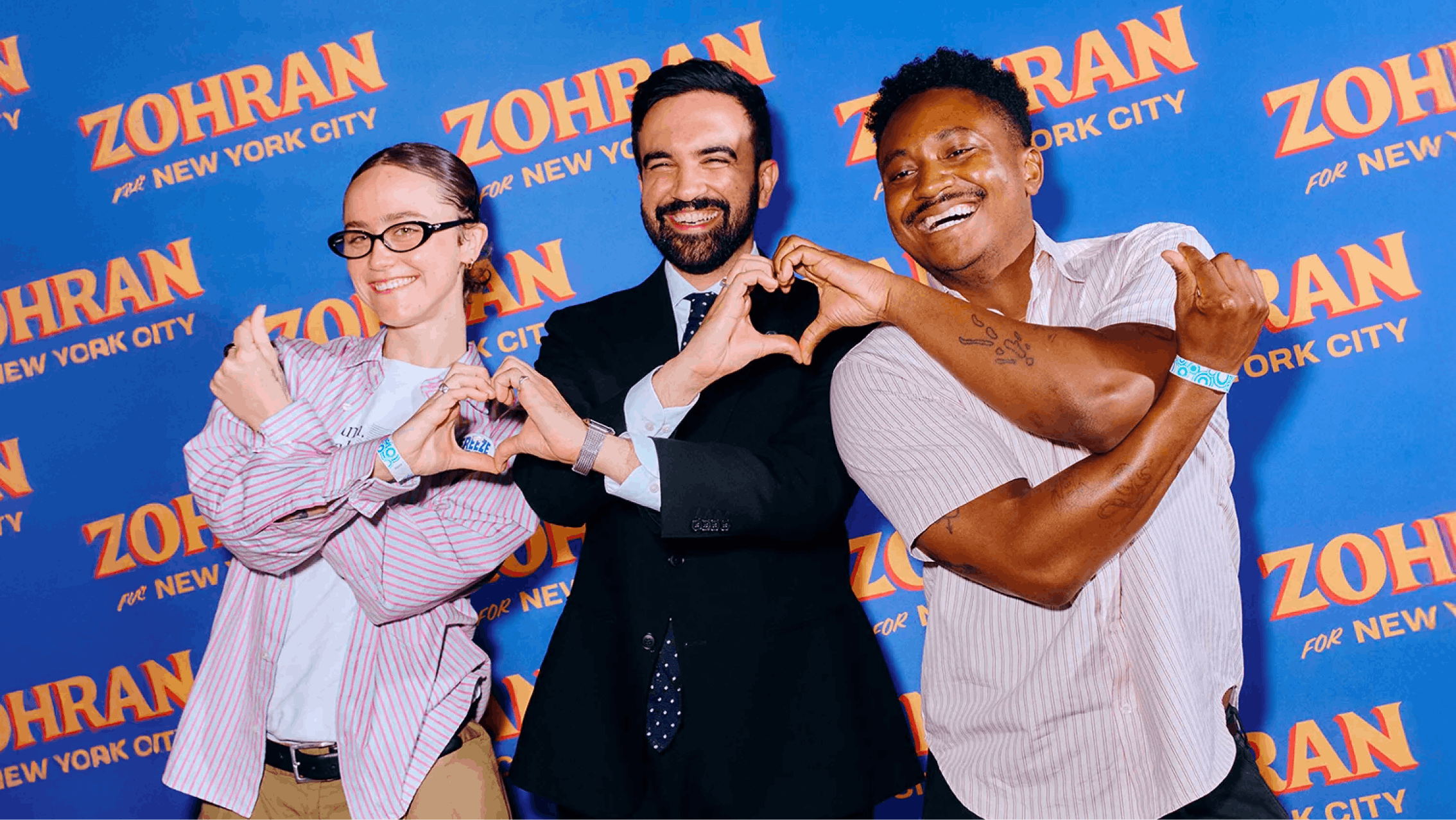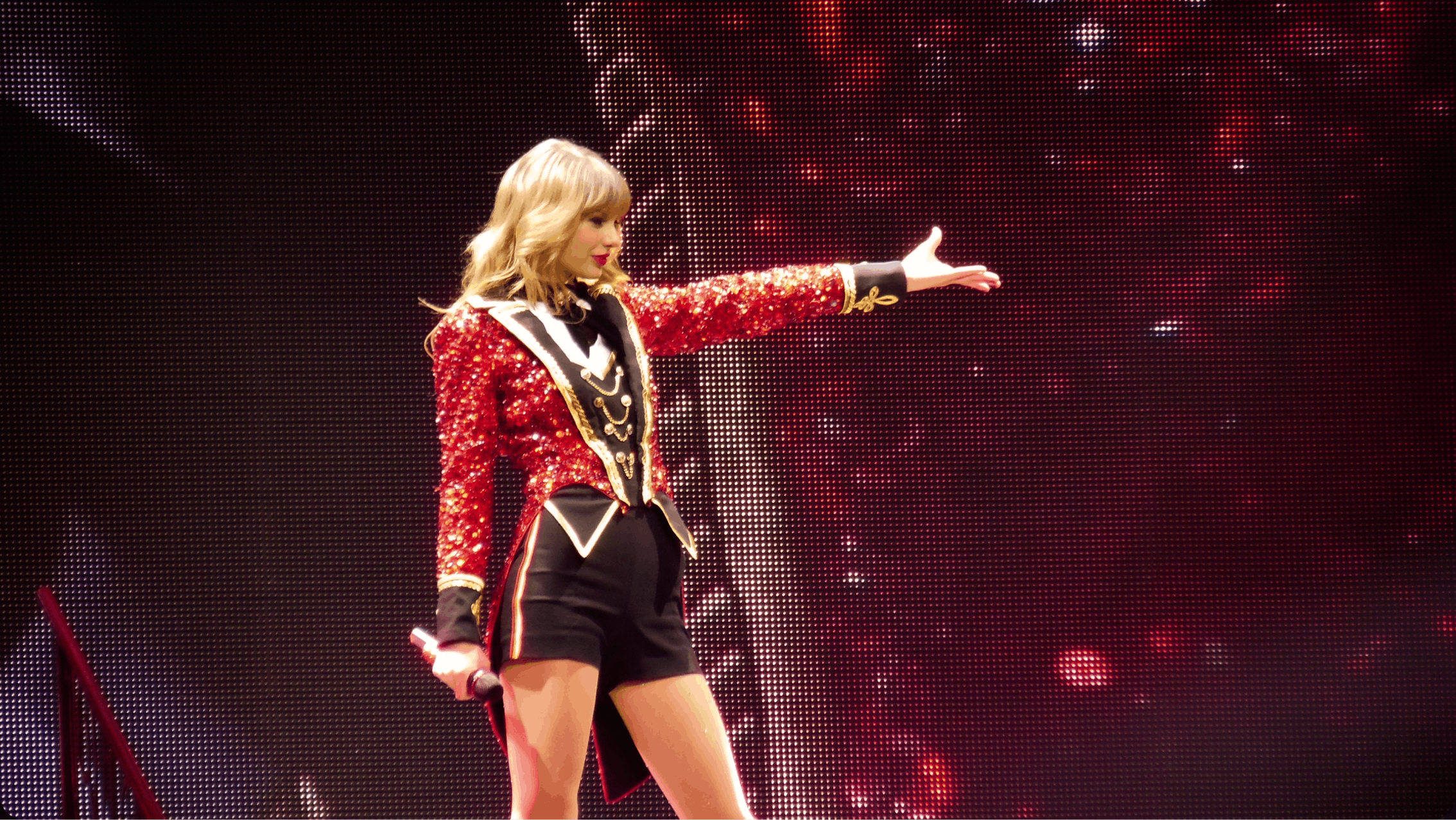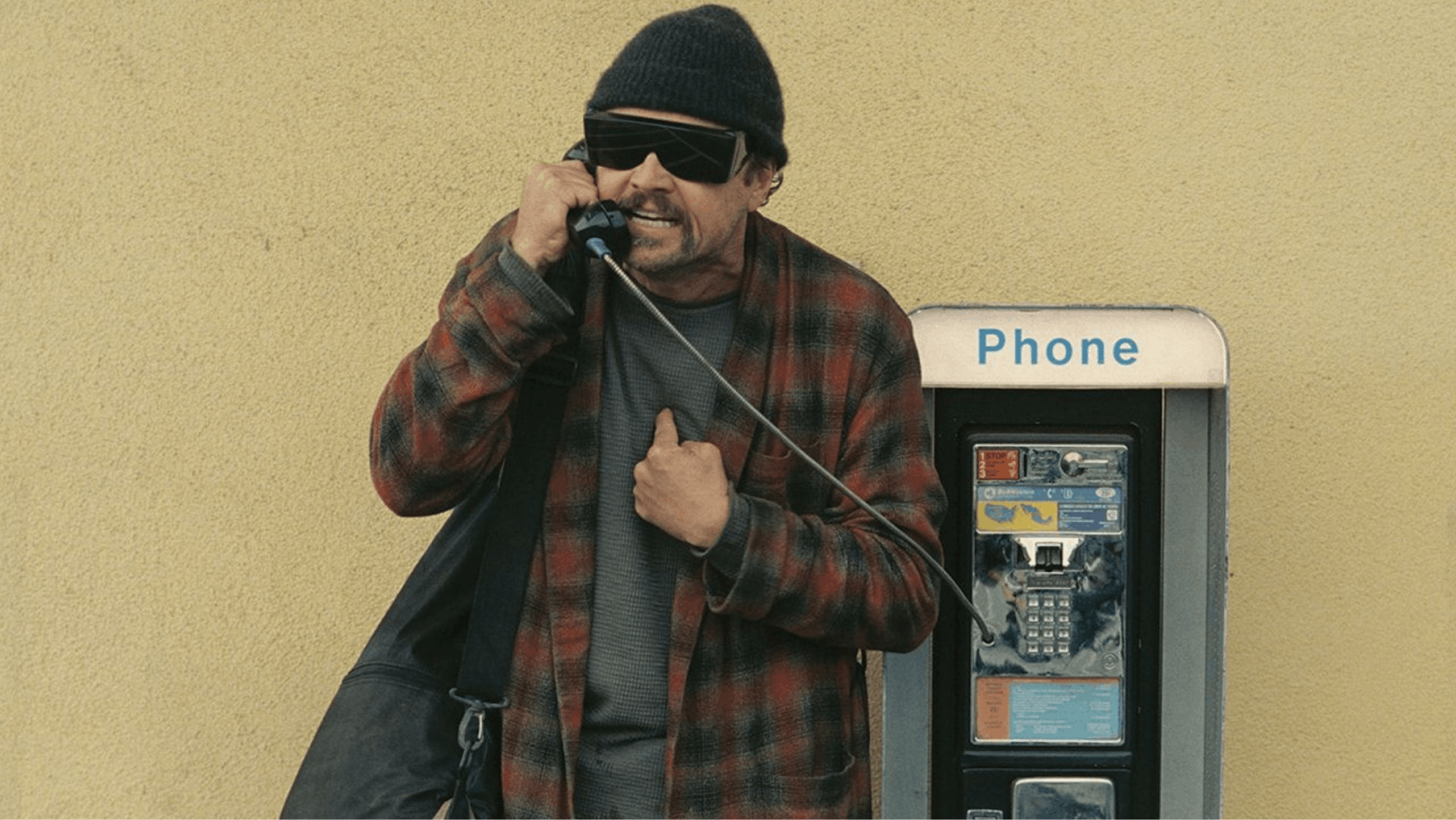Fossi stato un po’ più giovane - Rimmel, 50 anni dopo

Ecco la lezione rivoluzionaria di Rimmel: la forza dell’immaginazione come atto di ribellione. Nel 1975 De Gregori, con quest’album, riscrisse per sempre il linguaggio della canzone italiana, rendendolo più visivo, più emotivo, più libero. Lontano dai toni solenni e civili dei maestri precedenti, scelse la leggerezza, la visione, la fantasia. E oggi, in un tempo dominato dagli algoritmi, la sua voce ci ricorda che la creatività più grande è sempre quella più personale.
C’è un prima e un dopo Rimmel. Prima c’erano i cantastorie: Guccini, De Andrè, Gaber. Artisti che sapevano costruire racconti come storie o parabole morali, in cui ogni strofa era un episodio e ogni parola una dichiarazione di senso. La loro era una lingua densa, piena di gravitas e di impegno: canzoni che mettevano in scena la società, la coscienza, la lotta. In dischi come La buona novella, Non al denaro né all’amore né al cielo, Radici, Storia di un impiegato o Far finta di essere sani (solo per citare alcune delle opere più rappresentative della “sacra” triade nella prima metà degli anni ‘70) la musica diventava teatro civile, spesso attraversato da un pathos esistenziale. Poi arrivò Francesco De Gregori, e la canzone smise di “raccontare” per cominciare a suggerire, a evocare. Le storie si fecero visioni, le trame divennero immagini, i personaggi sparirono lasciando spazio ai simboli. Era come se la realtà, improvvisamente, si fosse fatta leggera, sospesa, quasi felliniana: non più l’urgenza di dire il mondo, ma la libertà di evocarlo attraverso frammenti, sogni, illusioni. La dimensione onirica per fuggire dalla “scadenza” della realtà, la sua banalità, la sua prevedibilità, così come ci insegna il protagonista (alter ego di Paolo Sorrentino) in “È stata la mano di dio”.
Era il 1973 quando, a ventidue anni appena, De Gregori pubblicò il suo primo album solista, Alice non lo sa. Dentro c’era già tutto: l’irruzione di un linguaggio che sembrava provenire da un’altra latitudine emotiva. “Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole” – una frase che non spiegava nulla eppure illuminava tutto. Una canzone che rifiutava il racconto lineare, preferendo la giustapposizione di immagini, di frammenti, di intuizioni poetiche che restavano sospese, come in un sogno. Un modo nuovo di scrivere, quasi eretico rispetto alla logica della canzone d’autore italiana, ancora legata alla narrazione.
De Gregori non voleva essere (solo) un cantore popolare, non cercava la morale. Portava dentro le influenze anglosassoni di Bob Dylan, la libertà visionaria di chi costruisce mondi per suggestioni. Lui ha sempre rifuggito l’etichetta di “surreale” (come qualsiasi altra etichetta), ma la novità era tutta lì: la parola non serviva più a spiegare, ma a evocare. La verità non era nei fatti, ma nelle sensazioni che lasciavano. In questo senso, De Gregori sta alla musica italiana — e forse anche europea e mondiale — come il surrealismo e l’arte astratta stanno all’arte figurativa: un salto di paradigma, una rottura che non nega la realtà, ma la reinventa attraverso nuovi codici.
Quando nel gennaio del 1975 uscì Rimmel, il suo terzo album, Francesco non aveva ancora ventiquattro anni. E l’Italia musicale non fu più la stessa. Quel disco fu una svolta estetica e linguistica. Non solo per la scrittura, ma per il suono, per la postura, per il modo in cui De Gregori sembrava cantare senza voler convincere nessuno. Rimmel, la canzone, è una dichiarazione di poetica: “E qualcosa rimane, tra le pagine chiare e le pagine scure.” Il linguaggio diventa pittura: niente spiegazioni, solo immagini che si rincorrono come fotogrammi di una memoria collettiva.

In Pablo, in Pezzi di vetro, in Buonanotte fiorellino – quest’ultima dylaniana fino al midollo – ma anche in Piano bar, riferita polemicamente all’amico-rivale Antonello Venditti, e in Il signor Hood, probabilmente ispirata alla figura di Marco Pannella nella sua dimensione imperscrutabile e difficilmente interpretabile, si sente la consapevolezza di un autore che ha deciso di emanciparsi dal realismo. È un’Italia diversa quella che canta: un’Italia filtrata attraverso i sogni, le nostalgie e le visioni leggere. È la nascita di una forma nuova di canzone, che abbandona la gravitas per farsi immaginazione pura, linguaggio dell’anima più che della realtà.
La rivoluzione di De Gregori non fu gridata, fu sussurrata. E proprio per questo travolse tutto.
Lucio Dalla, Ivan Graziani, Pino Daniele, Vasco Rossi, e più tardi Samuele Bersani, Daniele Silvestri, Niccolò Fabi: tutti, in un modo o nell’altro, si sono misurati con quella libertà linguistica. Persino Fabrizio De Andrè ne rimase colpito. Nel 1975, mentre Rimmel scalava le classifiche, usciva il suo Volume 8, scritto a quattro mani proprio con De Gregori: un disco in cui si sente l’eco del “Principe”, dalla costruzione ellittica dei testi fino a certe inflessioni narrative che si allontanano dal modello francese di Brassens per guardare oltreoceano, verso Dylan.
Lo stesso De Andrè, qualche anno dopo, lo riconobbe con la sua consueta lucidità: «In quegli anni ho guardato molto a Dylan, ma anche a De Gregori. Lui riusciva a scrivere come nessun altro in Italia, con quella libertà di immagini che io non avevo ancora», diceva in un’Intervista a «Ciao 2001» del 1979.
Una libertà che – dirà più tardi a Vincenzo Mollica – lo portava a considerarlo “il più bravo di tutti”. Una stima profonda, reciproca, che segnava l’inizio di una nuova stagione della canzone italiana: quella in cui le parole non spiegavano più, ma suggerivano.
Ciò che colpiva non era solo la profondità delle parole, ma la loro ambiguità. Rimmel è un disco che non chiude mai un significato: ogni brano è aperto, poroso, attraversabile. È come se De Gregori avesse costruito un linguaggio in cui ogni ascoltatore potesse trovare la propria storia. E forse per questo, a distanza di cinquant’anni, continua a parlarci.
La sua attualità non sta tanto nel suono – inevitabilmente datato – ma nello sguardo. In quell’idea che la canzone (e l’arte) possa essere insieme intima e universale, personale e collettiva. È la libertà di chi, a ventitré anni, scrive senza filtri, senza calcoli, con una disarmante fiducia nella forza della parola. Un’età in cui si osa dire anche ciò che non si sa e, forse, non si può spiegare.
Oggi, in un tempo in cui la creatività sembra imbrigliata da algoritmi, strategie e metriche di successo, la storia di Rimmel ci ricorda qualcosa che abbiamo forse dimenticato: la potenza della giovinezza come spazio di autenticità. Forse ingenua, certamente radicale. È la libertà del “non sapere ancora”, quella che permette di inventare linguaggi nuovi proprio perché non ci si è ancora piegati alla paura di sbagliare.
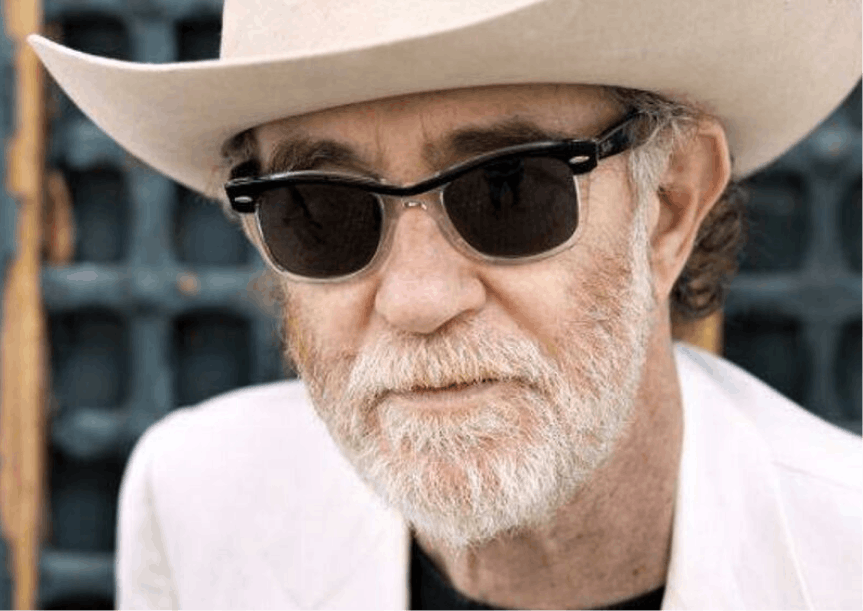
De Gregori, come detto, scrisse Rimmel quando non aveva neanche ventiquattro anni. Oggi quell’età, nella percezione collettiva italiana, sembra troppo giovane per essere davvero ascoltata, troppo acerba per guidare, troppo fragile per innovare. Ma è forse proprio lì che nascono le rivoluzioni: nei momenti in cui l’istinto è più forte dell’esperienza, e la curiosità supera la prudenza.
Ecco perché Rimmel non invecchia. Perché ogni generazione può specchiarsi in quella sua ricerca di libertà. Non è un disco che parla del passato, ma del presente che ognuno porta dentro di sé. Come direbbe Calvino di un classico, Rimmel è un’opera che “non ha mai finito di dire quel che ha da dire” — e continua, mezzo secolo dopo, a parlarci con la stessa voce limpida e misteriosa di allora.
Perfino la sua copertina racconta qualcosa di questa ambiguità. L’immagine scelta – una riproduzione di una cartolina d’inizio Novecento con una donna di profilo, gli occhi bassi, un pudore quasi sospeso – fu ideata dal grafico della RCA, Francesco Logoluso. De Gregori, però, aveva immaginato tutt’altro: una copertina ispirata alla Marilyn di Andy Warhol, con il volto di una donna emancipata, disinibita, forse con il rimmel che cola dopo una notte d’amore. L’opposto, concettualmente. In mezzo a queste due visioni – la donna composta e quella scomposta, la quiete e il disordine – si muove tutta la poetica di Rimmel: l’equilibrio fragile tra maschera e verità, tra disincanto e nostalgia, tra la bellezza che si trucca e quella che si lascia guardare.
La storia di Rimmel è anche una lezione di comunicazione, senza bisogno di forzarla: l’innovazione non nasce dalla complessità tecnica, ma da un cambio di sguardo. De Gregori non inventò nuove parole, ma un nuovo modo di accostarle. Non costruì una struttura più elaborata, ma un immaginario più libero. È ciò che ogni brand, ogni impresa, ogni comunicatore dovrebbe ricordare: non serve dire di più, serve dire diversamente.
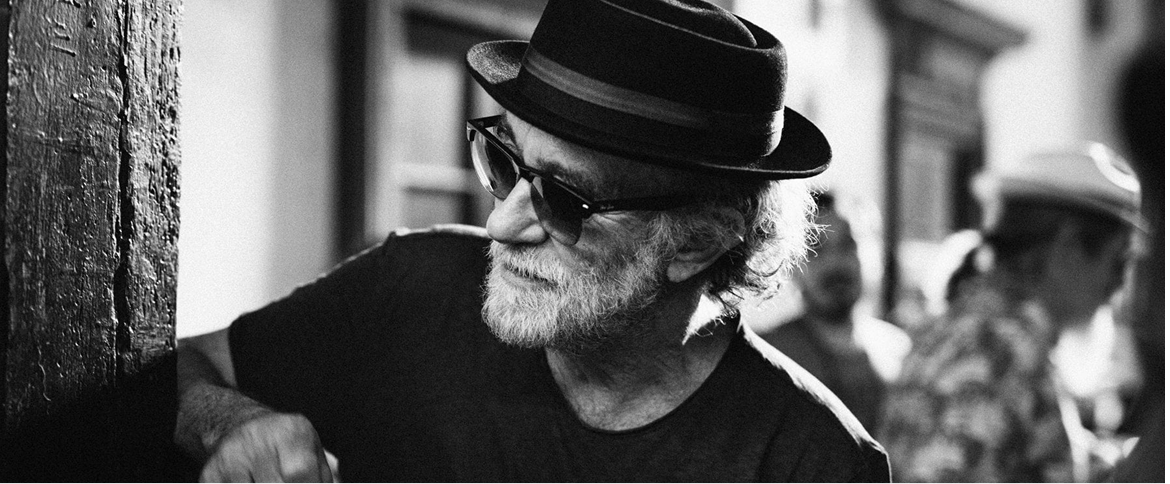
La differenza tra informare e ispirare sta tutta lì – tra la cronaca e la poesia. Viene in mente quando, durante la cerimonia degli Oscar del 2020, Bong Joon-ho (regista di Parasite) rese omaggio a Martin Scorsese citando una delle sue frasi più celebri: “The most personal is the most creative”. È una lezione che vale anche e soprattutto per chi comunica oggi: la forza non nasce dall’essere più sofisticati o tecnici, ma dal saper essere personali, nel modo più autentico possibile. È lì che la creatività diventa universale, come accadde con Rimmel, un’opera che, paradossalmente, parla a tutti proprio perché nasce da un gesto profondamente personale.
E allora, 50 anni dopo, Rimmel continua a guardarci come una carta che cambia volto a ogni sguardo. Ogni volta che lo ascoltiamo, ci sembra nuovo. Forse perché, come la giovinezza, non finisce mai davvero: resta sospesa, a metà tra ciò che siamo stati e ciò che potremmo ancora diventare. D’altronde, si sa «fossi stato un pò più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia».