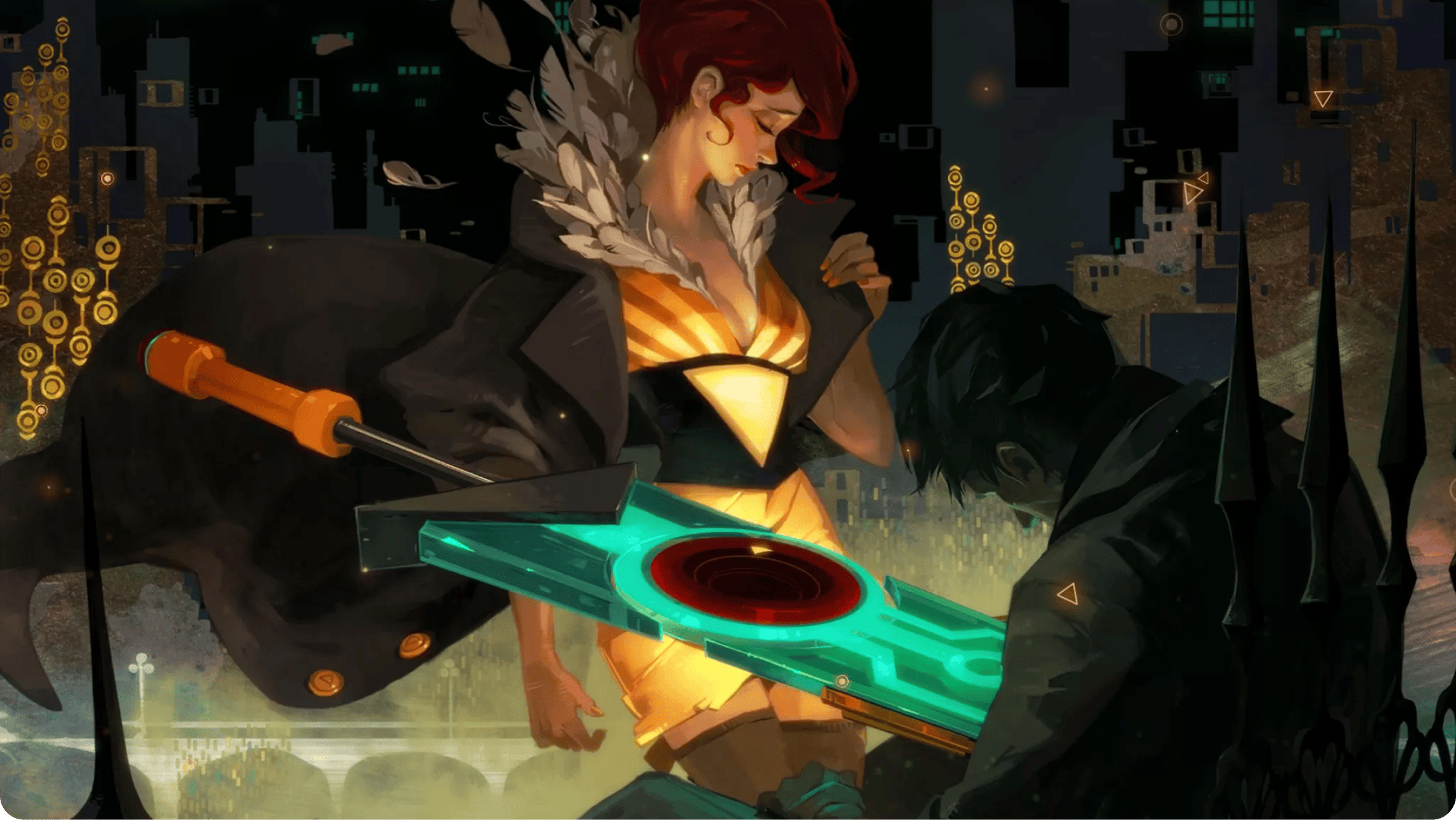Se muore la velocità, si salvi la meraviglia!

Fermarsi, osservare, farsi delle domande. Arti di cui spesso dimentichiamo il valore, ma che, in fondo, rappresentano il fine ultimo della nostra esistenza.
Da Ulisse a Wim Wenders, un viaggio tra chi, in modo diverso, ha raccontato il ruolo determinante che la meraviglia ricopre nelle nostre vite.
Cosa succede quando ci fermiamo e osserviamo la realtà con stupore? E che cosa significa meravigliarsi? Leggendo “Resisti, cuore. L’Odissea e l’arte di essere mortali”, il libro di Alessandro D’Avenia, mi ha catturata un capitolo dedicato proprio a questo tema. In un mondo che gira a velocità stratosferiche e nel quale siamo costantemente bombardati da stimoli e informazioni differenti forse, talvolta, vale la pena fermarsi, o anche solo rallentare. Si tratta di un atteggiamento che ci permette di osservare, di scegliere come agire, di sbagliare, di evolvere… di meravigliarci.

Nel libro, D’Avenia sostiene di voler esercitare un modo di essere e guardare il mondo chiamato filomitia, ovvero «un’arte di vivere che consente di non perdere la meraviglia, un’iniziazione continua alla vita, una cura per guarire la mente dal suo continuo vagabondare fuori dalla realtà». L’autore mette in pratica questo percorso attraverso la scrittura.
Stiamo parlando di un concetto che ha attraversato decenni di filosofia; ne parlava Aristotele in apertura della Metafisica: «Gli esseri umani hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia» (Metafisica, A, 2, 982b, trad. it. di Giovanni Reale). Secondo il filosofo, la meraviglia non è un’emozione rassicurante, ma una sfida al rischio che comporta uscire da sé, alla ricerca del respiro autonomo e sempre più profondo. Anche Platone si collocava nello stesso filone di pensiero: «L’essere pieno di meraviglia è proprio del filosofo. Sì, il principio della filosofia non è altro che questo, e chi ha detto che Iride è figlia di Taumante [“thaumazein” = meravigliarsi] non mi pare abbia sbagliato genealogia» (Platone, Teeteto, 155d).
Tornando ai giorni nostri, per D’Avenia, «se la filosofia è l’amore per la sapienza, la filomitia è l’amore per il racconto (inteso come trama della vita)». Nel libro si occupa della meraviglia del racconto odissiaco, che secondo lui costringe a fermarsi, ad ascoltare e a cercare. «Questo tipo di meraviglia è come la vertigine: ci porta a uscire da noi stessi, a vivere non più per abitudine, ma per inquietudine».
Il viaggio di Ulisse verso la riscoperta di sé
Ulisse, nel suo viaggio, affronta innumerevoli sfide e avventure, di felicità ma anche di dolore, che lo portano a fiorire, a essere quello che è: a ritrovare se stesso. Il racconto odissiaco, secondo D’Avenia, è una metafora della nostra vita che scorre, è una narrazione nella quale, in qualche misura, ci identifichiamo. Senza storie l’essere umano non riesce ad abitare il tempo e a dargli un senso, perché è un essere narrativo che rivive il passato raccontandoselo e modificandolo, si prepara al futuro narrandoselo in anticipo con tutte le sue possibili varianti e sta nel presente come materia prima di tutti i suoi racconti. Cerchiamo ovunque storie, ogni giorno e in ogni forma possibile. E nelle storie troviamo la nostra meraviglia. Allora perché la cerchiamo nel mito?
Riprendiamo il discorso dalla definizione di D’Avenia: «La meraviglia da un lato è la percezione di una novità che si impone improvvisamente e a cui non ci si può sottrarre; dall’altro è la paralisi di ogni attività in favore di un momento di contemplazione». Questa contemplazione si può tradurre in un fermarsi, osservare, farsi domande.
Aristotele nella Metafisica sostiene che chi mette in dubbio e pratica la meraviglia riconosce di non sapere (per questo, la filosofia nasce perché si mettono in discussione gli assunti che prima erano dati per certi). E il mito è costituito da un insieme di avvenimenti che destano questa condizione. Ciò non significa che siano situazioni belle o piacevoli, ma che in un certo modo hanno un significato e portano il protagonista verso una meta, aggiungendo valore alla sua crescita. Così accade a Ulisse: fa esperienza di sé a livello profondo e così facendo riconosce il proprio destino.



Che cosa vuol dire fare esperienza?
Oggi, immersi nella velocità, spesso siamo portati a pensare che fare esperienza significhi provare tante cose all’infinito, per migliorarci sempre di più. Esperienza, in realtà, non è accumulare un’infinità di vissuti come fossero esperimenti, ma riconoscersi in un vissuto e fiorire grazie a quel vissuto, fosse anche solo uno.
Come scrivono Maura Gancitano e Andrea Colamedici, due filosofi contemporanei che divulgano la filosofia in relazione all’attualità con Tlon, nel libro Lezioni di meraviglia, «il miracoloso si manifesta solo in uno spazio in cui è possibile sbagliare e non ha niente a che fare con l’efficacia, non conferma il mondo ordinario e non è un processo di normalizzazione. [...] Il fatto è che noi associamo l’infelicità alla vuotezza, e non riusciamo a capire che una vita felice è una vita in cui è presente anche l’infelicità».
Uscendo per un momento dal libro in sé e riflettendo sul tema, si può osservare come questo tocchi probabilmente degli aspetti presenti anche nella nostra società, portati a galla, per esempio, attraverso i film. A questo proposito, mi viene in mente il recente film Perfect Days (2024) di Wim Wenders: Hirayama vive da solo e conduce un’esistenza semplice e silenziosa, caratterizzata da una ripetitività a tratti ossessiva delle attività quotidiane. Sembra il ritratto della solitudine di un uomo che ha fatto pace con i propri errori e accettato così la propria esistenza. Questo equilibrio trova la sua epifania nella scena finale, accompagnata dalla suggestiva colonna sonora Feeling Good di Nina Simone.
Appare come la parabola di un’esistenza in slow motion, un invito a sperimentare la tanto desiderata “vita lenta”. Una vita in cui non si rinuncia a provare e sbagliare, ma nella quale ci si concede il tempo per riflettere. Dopotutto non è trovare un significato in ciò che facciamo il motore che ci spinge ad andare avanti? E non è proprio il farsi delle domande, mettere in dubbio, ciò che ci fa sentire vivi e in movimento?

L’anticamera della trasformazione
Raccontare e costruire una storia significa anche questo: intercettare quale sia il percorso più adatto da intraprendere, a volte fermandosi e lasciandosi attraversare dal dubbio. Avere più domande che risposte è spesso sfidante, ma porsi nella condizione di non sapere significa anche osservare, indagare, conoscere, sperimentare. E scoprire l’ignoto. Proprio come Ulisse fa nel suo viaggio e proprio come D’Avenia affronta il racconto. Così si legge in Lezioni di meraviglia: «Il dubbio è l’anticamera della trasformazione: accogliere il dubbio come compagno di viaggio significa disporsi a essere completamente diversi da un istante all’altro». Questo significa, a volte, rallentare. Non ci perderemo nulla, ma magari scopriremo qualcosa di inaspettato che non vedevamo correndo. Qualcosa di meraviglioso.