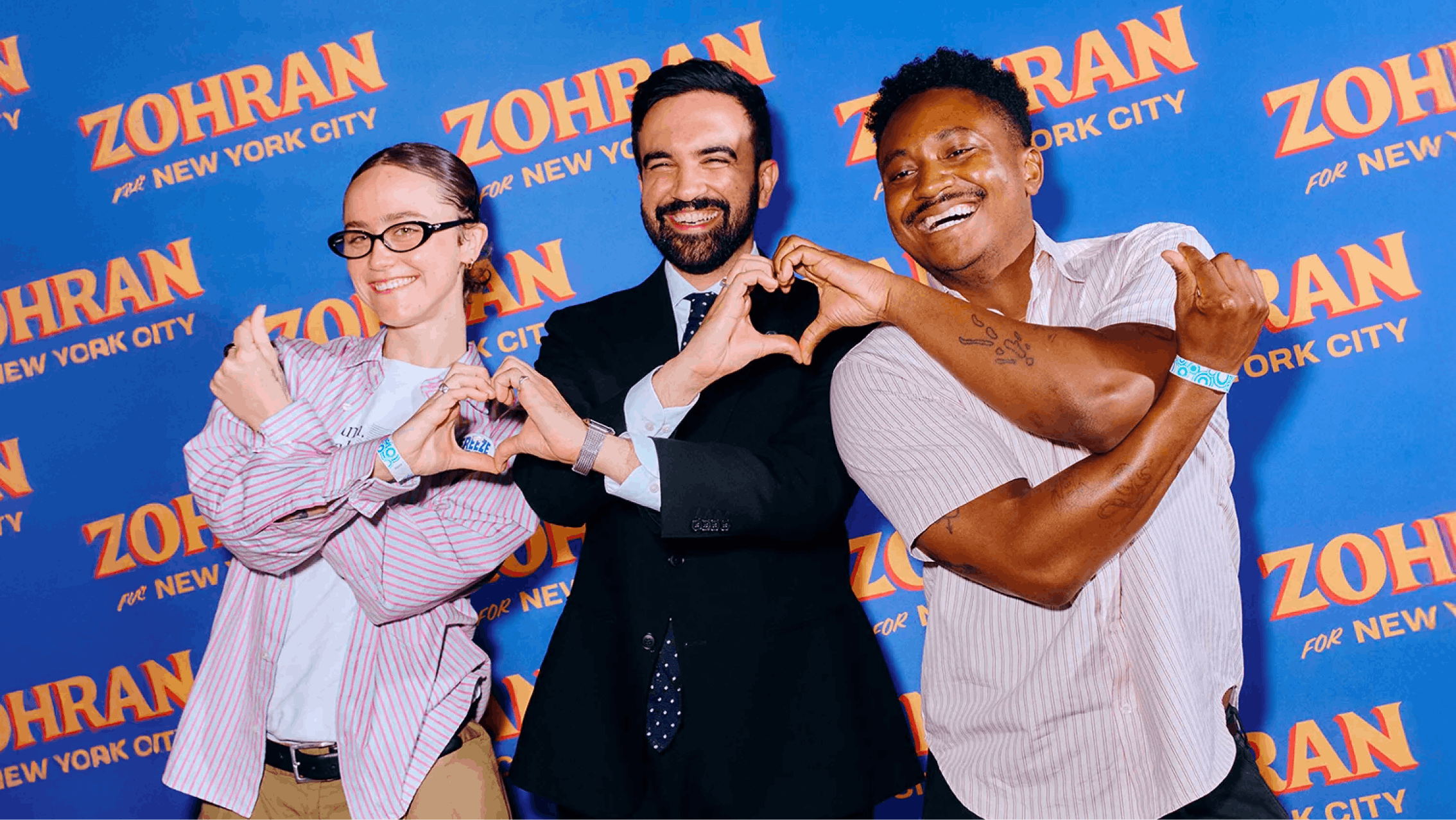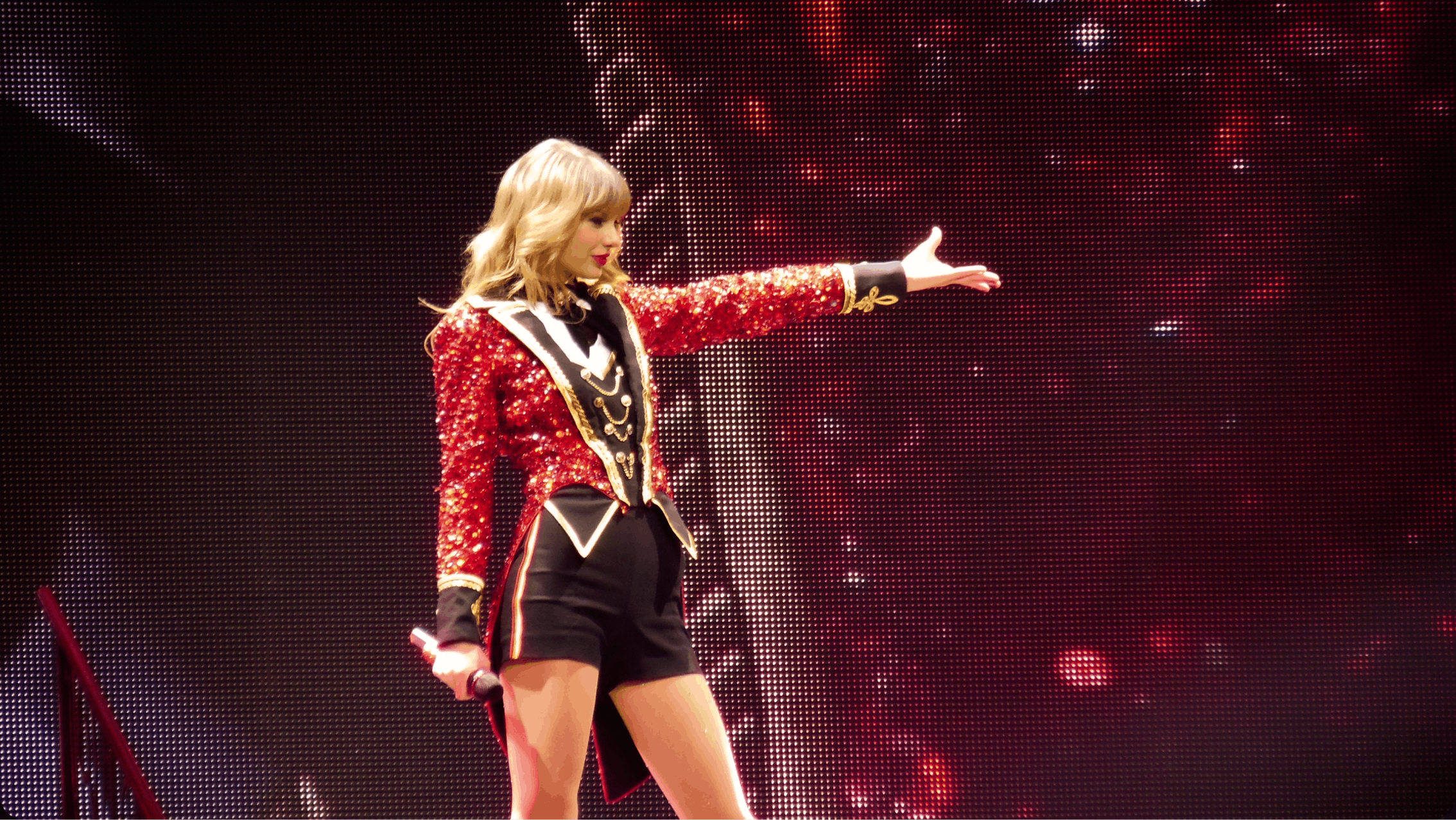Noi, le storie e l’Ai generativa. Un aiuto, ma la creatività rimarrà degli uomini
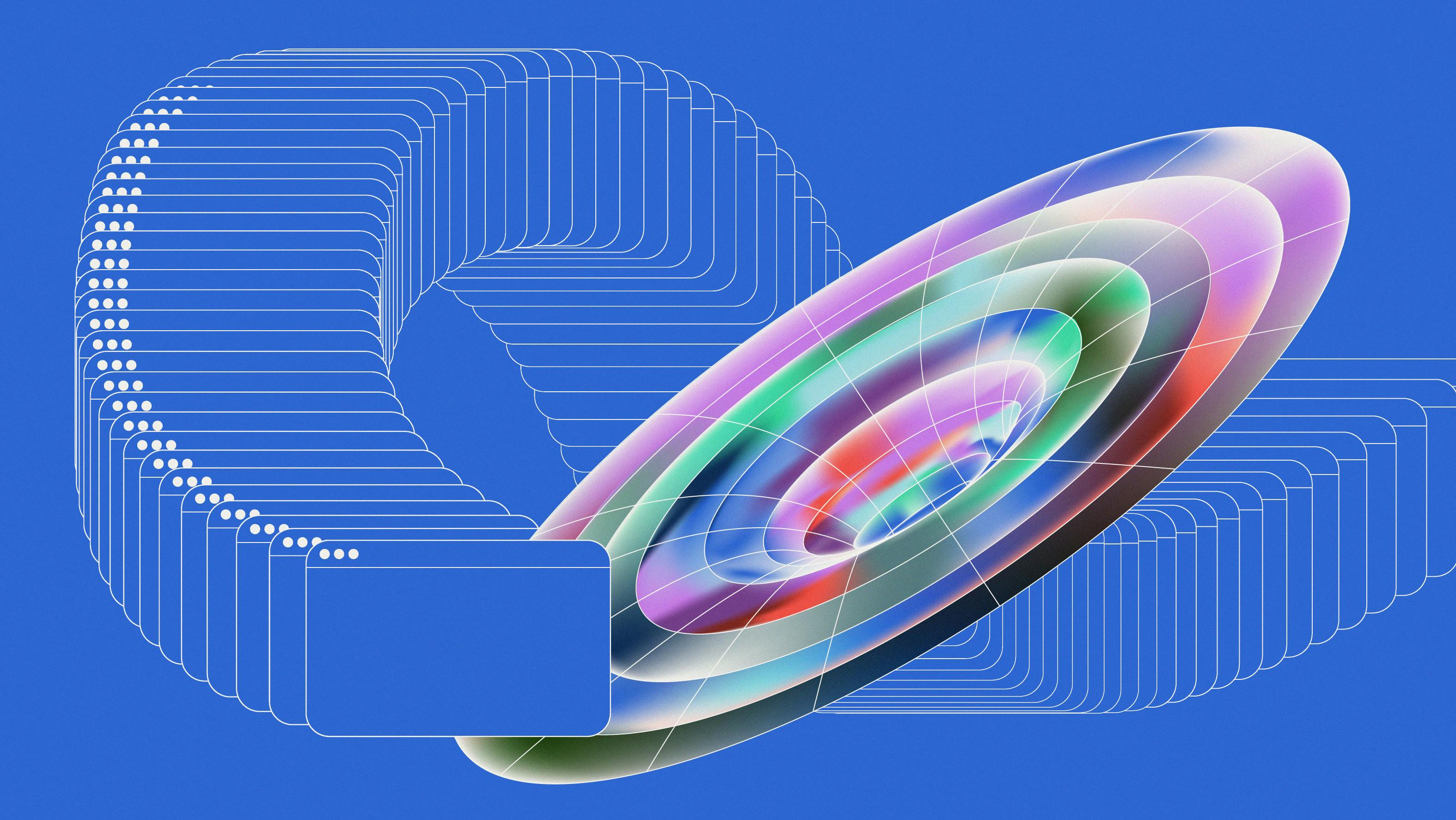
L’Ai ormai è ovunque. Catalizza fascinazioni e alimenta paure, solleva dubbi e offre opportunità. Noi di Bea stiamo pian piano imparando a utilizzarla, consapevoli che può essere un validissimo aiuto ma che il potere evocativo di una storia dipenderà sempre e comunque dalla creatività umana
«Ma perché non scriviamo un articolo sul rapporto tra l’intelligenza artificiale generativa e le storie? In fondo, è ormai parte integrante di quello che facciamo, no? Non possiamo ignorare il progresso tecnico e le potenzialità di un mezzo che potrebbe cambiare radicalmente ciò che facciamo». «Proviamoci, anche a costo di non essere i più originali, ma riflettiamo su noi stessi e il nostro rapporto con la nuova tecnologia».
In Bea ci confrontiamo quotidianamente sui temi e le storie che riguardano il nostro lavoro, è un’esigenza, una necessità, è il percorso che ci porta a essere quello che siamo e a fare il nostro lavoro guardando all’evolvere delle cose. Per questo un tema come quello dell’Ai (perché si chiama Ai, almeno su questo non vogliamo sentire ragioni), delicato e complesso andava indagato perché, in fondo, «c’è moltissimo da dire» anche se quasi tutto è stato già detto, e il pericolo di ridondanza è dietro l’angolo.
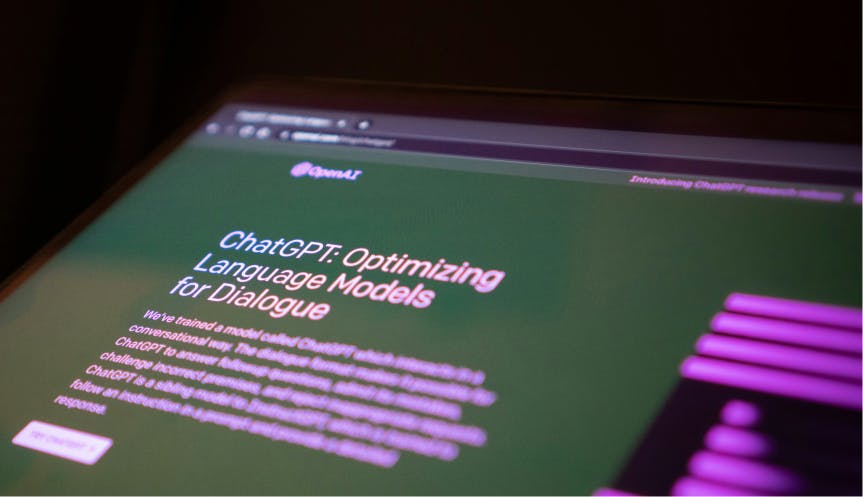
Ai o Ia?
Tra i tanti dubbi e perplessità che gravitano attorno al tema dell’intelligenza artificiale, c’è n’è uno che secondo noi non ha motivo di esistere. Facciamo un passo indietro. È il 1956, siamo all'Università di Dartmouth, nel New Hampshire. Durante un convegno, l’informatico statunitense John McCarthy conia il termine “artificial intelligence", segnando la nascita della disciplina. Nessuno ha mai pensato di invertire le lettere di pc per virare verso il “calcolatore personale”, o ha adottato l’acronimo “rim” («ragnatela intorno al mondo») in luogo dell'anglosassone “www” («world wide web») come prime tre lettere dell’indirizzo del proprio sito web. In un tempo in cui gli anglicismi tendono sempre più a dominare il nostro quotidiano nella quasi indifferenza generale, non ci sembra proprio il caso di invocare qualche forma di sovranismo linguistico per un’espressione che è inglese per natura.
Tutti parlano di intelligenza artificiale, quasi tutti vogliono utilizzarla, molti fanno credere di aver già capito tutto: dei prompt, dei bias, delle implicazioni etiche, del fatto che «guarda, te lo dico oggi, sicuro entro 10 anni ci toglierà il lavoro». In ogni caso, la realtà è che con una tecnologia dotata di un tale portato rivoluzionario, nessuno può avere certezze sul reale impatto e sugli eventuali limiti di utilizzo. Non lo sa la politica, che a fatica sta cercando di definirne i contorni legislativi, non lo sa la scienza, di certo non lo può sapere la comunicazione.
A noi, ad esempio, piace ammettere di non aver capito esattamente tutto. Anzi. Certo, con gli algoritmi di Ai generativa ci stiamo pian piano prendendo confidenza, li sperimentiamo, ci giochiamo come si fa con il nuovo, bellissimo, cane dei vicini, entusiasti ma con quel minimo di distanza perché «è sempre un cane, non lo sai mica come reagisce». Negli ultimi tempi possiamo dire di aver integrato gli algoritmi di intelligenza artificiale nel nostro flusso di lavoro. Ci rivolgiamo ad essi per mettere alla prova un progetto, per creare delle basi di immagini e contenuti testuali da sviluppare. In alcuni casi abbiamo creato dei “super esperti di identità aziendali”, in grado di restituire cultura, storia, valori di un brand,per poi impostarci sopra una narrazione. Abbiamo capito che, per ottenere dei risultati, gli algoritmi vanno accuditi come dei bambini, occorre dedicarci ogni giorno tempo ed energie così da renderli efficaci suggeritori. Li formiamo.
Insomma, sentiamo che ogni giorno stiamo imparando qualcosa in più. Ma la strada è ancora lunga, quindi abbiamo provato a fermarci un attimo e provare a ragionare su quanto fatto fin qui e su quanto ci potrebbe riservare il futuro.
Per farci guidare nella scoperta del rapporto tra Ai generativa e narrazione, abbiamo deciso di disturbare tutta la squadra di Bea, gente che del racconto di storie ne fa un lavoro. «Se un cliente vi chiedesse di creare un contenuto usando interamente l’Ai, cosa pensereste?». In linea generale, l’idea su cui sembrano concordare tutti è che possa essere una grande opportunità per migliorare il processo creativo. Un “collega” a cui chiedere verifiche, conferme, input…per stimolare l’idea o aggiungere un qualcosa in più a un contenuto in fase di definizione. «Più che far scrivere una storia all'Ai, le chiederei di darmi qualche suggerimento su possibili personaggi, ambientazioni, ecc…», «è interessante dialogare con questi strumenti per far emergere qualcosa di inedito e, soprattutto, di valore a livello di design», sono alcune delle risposte.
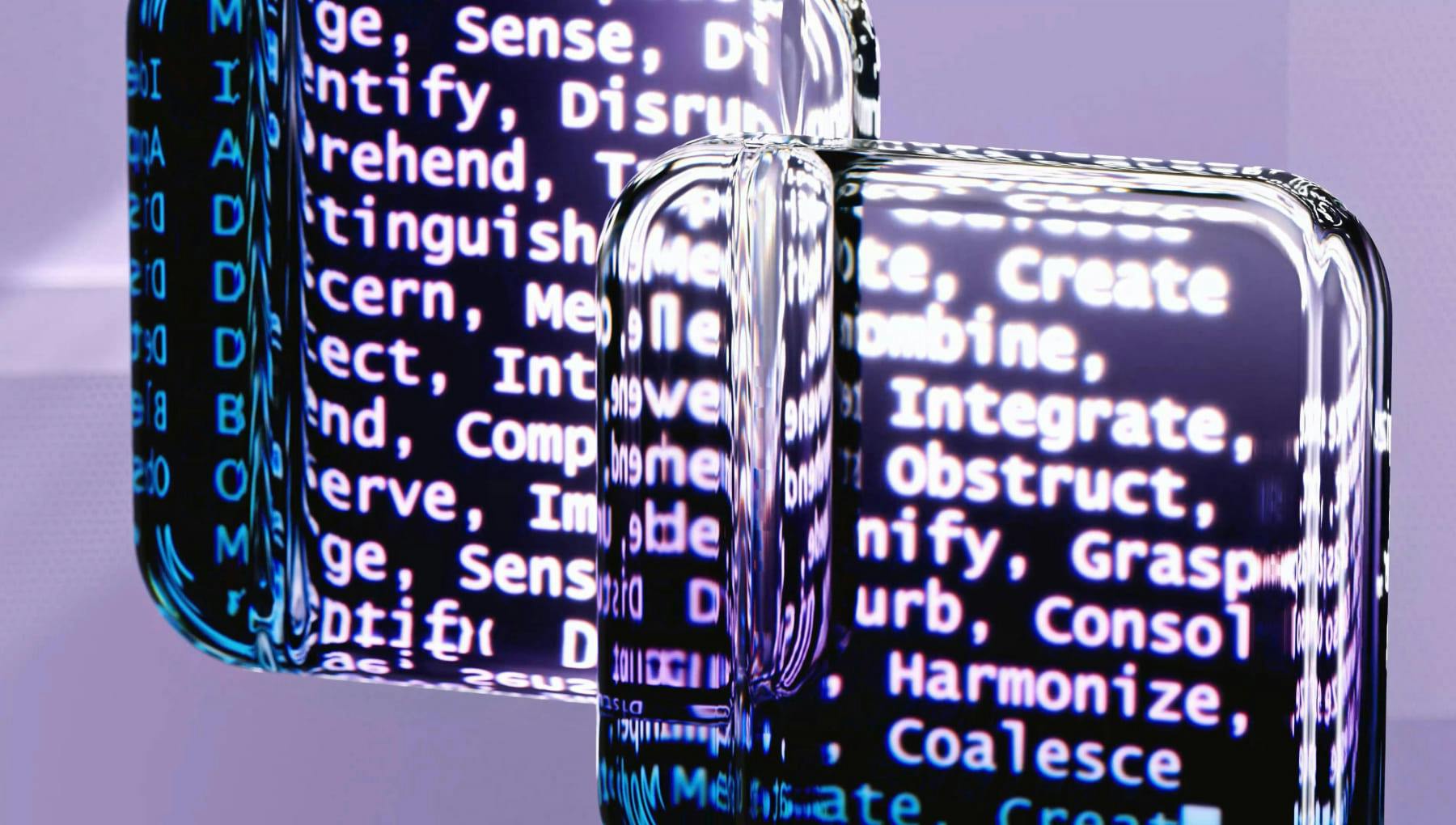
Allo stesso tempo, tra i corridoi, non mancano i dubbi. C’è chi crede che sia difficile ottenere un qualcosa di nuovo, perché «l'Ai tende a generare cose già viste e solo combinate tra loro, spesso lontane da ciò che si vuole realmente», chi invece si domanda filosoficamente «siamo sicuri che la produttività infinita sia l’obiettivo da perseguire?» o «come può essere programmata prendendo solo il buono dall’essere umano che la istruisce se noi per primi siamo un’alternanza tra bene e male, in continua tensione tra loro?». A questo si unisce il timore di un uso manieristico del mezzo, utile solo a «sentirsi i primi a sperimentare, senza una reale opportunità operativa». Per non parlare delle implicazioni etiche, sulla privacy, sulla tutela del diritto d’autore. Soprattutto quest’ultimo è uno dei temi più critici quando si parla di Ai generativa, dal momento che la macchina ci restituisce spunti, contenuti, informazioni sulla base di quanto apprende da opere prodotte da terzi, che in cambio non ricevono alcun compenso economico o di visibilità. Quindi, nel momento in cui si crea un contenuto bisogna tenere in considerazione che “l'idea creativa” alla base non è originale, bensì frutto del centrifugato di un numero indefinito di idee di artisti visuali, scrittori, musicisti ignari che il loro lavoro venga utilizzato per istruire algoritmi. I recenti casi giudiziari di Getty Images contro Stability AI e del New York Times contro Open AI sono solo due tra i più famosi. In ogni caso il tema è complesso, come dimostra ad esempio la vicenda del filosofo e artista digitale Francesco D’Isa e della sua graphic novel Sunyata, interamente illustrata tramite Ai e vittima di una (esagerata?) ondata di critiche proprio per questioni relative al diritto d'autore e ai dataset utilizzati.
Domande, riflessioni, dubbi “umani troppo umani”, alcuni dei quali, da bravi giornalisti, siamo andati a sottoporre direttamente alla fonte. Ecco il risultato:
«Ciao, cosa ne pensi riguardo al tema del copyright dell’intelligenza artificiale generativa e, in particolare, del fatto che per generare storie e/o immagini quest’ultima utilizzi materiale prodotto da altri?». ChatGPT, come spesso gli accade, tende a fare propria l’antica arte del cerchiobottismo: «Anche le opere derivate sono generate da algoritmi, è importante riconoscere la fonte del materiale utilizzato. In alcuni casi, tuttavia, l'uso di materiale protetto da copyright può essere giustificato sotto la dottrina del "fair use" (uso corretto), che consente l'uso limitato di opere protette per scopi come critica, commento, insegnamento e ricerca».
Questa “intervista” diventa invece più interessante e significativa per quanto riguarda il rapporto tra le storie e l’intelligenza artificiale generativa quando gli rivolgiamo la seconda domanda, quasi esistenziale: «E invece, come possiamo istruirti a fare del bene se noi stessi siamo composti di una natura ambivalente?». Visto il tema meramente filosofico, eravamo pronti a una non risposta, ma ChatGPT ci sorprende, e ribatte prontamente con dieci argomentazioni che per larga parte vi risparmiamo. In particolare, il passaggio maggiormente degno di nota è il seguente: «È essenziale definire chiaramente cosa significhi "fare del bene" in contesti specifici. Le definizioni etiche devono essere tradotte in regole e obiettivi chiari che l'Ai può comprendere e seguire».

In sostanza ci ricorda di essere nient’altro che un prodotto dell’azione umana, che agisce in base a delle scelte precise fatte da noi, e delle quali - come in qualsiasi contingenza personale e professionale che la vita ci presenta - sta a noi assumercene le responsabilità.
Un’assunzione di responsabilità con cui chi, come noi, racconta storie, si confronta quotidianamente. Come recita un passaggio del libro “Riscoprire il silenzio. Arte, musica, poesia, natura fra ascolto e comunicazione” di Nicoletta Polla-Mattiot - scelto come traccia della prova di italiano dei recenti esami di maturità - «concentrarsi sul silenzio significa, in primo luogo, mettere l’attenzione sulla discrezionalità del parlare. Chi sceglie di usare delle parole fa un atto volontario e si assume dunque tutta la responsabilità del rompere il silenzio. Qualsiasi professionista della comunicazione studia quando è il momento opportuno per spingersi nell’agone verbale: la scelta di «smettere di tacere» è un atto rituale di riconoscimento dell’altro». Non vi è motivo, dunque, per cui tale assunzione di responsabilità non debba valere anche in riferimento all’intelligenza artificiale. E noi siamo pronti ad abbracciarla, consapevoli che le idee creative e fuori dagli schemi sono e resteranno un patrimonio prettamente umano.