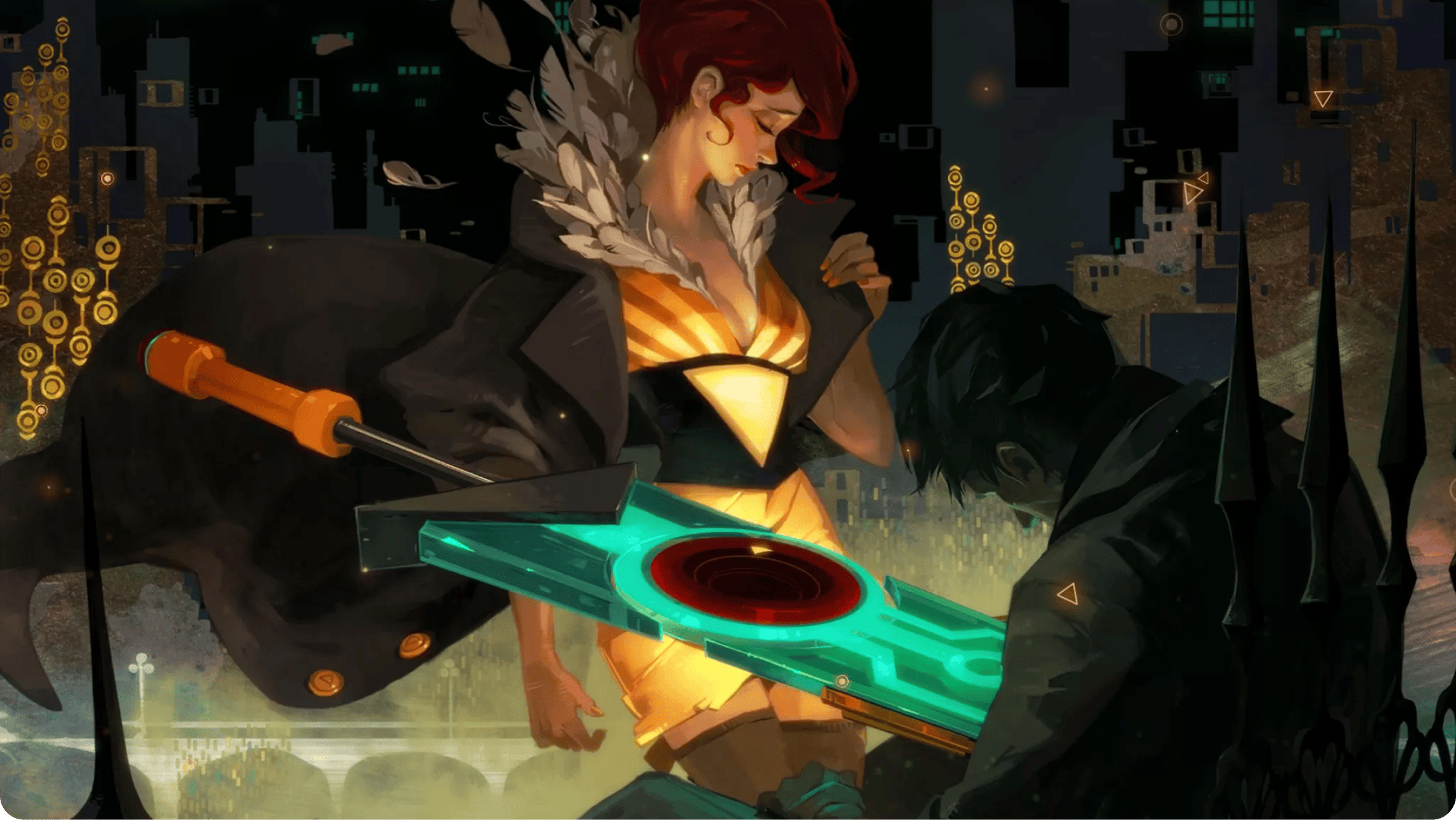Habemus pop: la religione alle prese con l’intrattenimento

In un contesto interconnesso anche la religione deve fare i conti con il mondo della comunicazione pop. I social ormai sono diventati una piazza dove tutto viene reso condivisibile con un tono spesso divertente. E pure il conclave non è passato inosservato.
«Ti sei iscritto al FantaPapa?», «Io tifo per Zuppi, quello che gira in bicicletta per Bologna», «Lo hai visto il meme del conclave con i personaggi di High School musical?». E ancora. «Hai saputo cosa mangiano i cardinali?», «Il frigobar degli alcolici di Santa Marta è finito in pochi minuti», «Secondo me vince il filippino».
Nella piccola parentesi tra la commozione per la morte di Papa Francesco e l’elezione lampo di Papa Leone XIV abbiamo assistito al proliferare di un fenomeno inedito: il conclave trasformato in evento pop, meme virale, scommessa da bar e da social.
La solennità dei marmi vaticani si è mescolata con l’ironia di TikTok, l’hashtag #FantaPapa è diventato trending topic, e la fumata bianca è stata seguita in diretta streaming da milioni di persone, forse, più per curiosità che per fede. Anche il gabbiano appostato vicino al comignolo della Cappella Sistina ha avuto un suo ruolo.
In quei giorni sospesi, Roma sembrava il set di una fiction globale, con cardinali in tonaca rossa al posto dei concorrenti del Grande Fratello, e un pubblico mondiale pronto a fare il tifo per il proprio “campione”, suggellando che anche la religione – o almeno la sua narrazione – è entrata definitivamente nell’ecosistema dell’intrattenimento. Ma com’è stato possibile?

Non è solo colpa (o merito) dei social. In un sistema mediatico ibrido anche i media tradizionali hanno seguito la scia, contribuendo a questa trasformazione: le dirette televisive con grafici da elezioni politiche, i giornalisti che si rincorrevano per strappare indiscrezioni da dietro le mura del Vaticano, gli opinionisti che si improvvisavano esperti di geopolitica ecclesiastica. Ma è stato il web – e in particolare il popolo di X, Instagram e TikTok – a dettare il tono: ironico, partecipativo e a tratti emotivo.
Il conclave è diventato un racconto collettivo. E come ogni racconto collettivo, si è adattato al linguaggio del tempo: sticker su WhatsApp, fan fiction su Reddit, filtri Instagram con l’aureola. Da “io tifo Zuppi” a “Papa spoilerato” fino ai thread sulle trame segrete tra i cardinali africani e latinoamericani, ogni angolo di questa elezione ha trovato la sua versione condivisibile.
Questo non significa necessariamente che la spiritualità sia scomparsa. Piuttosto, che la fede – o la sua rappresentazione – oggi deve confrontarsi con i meccanismi della comunicazione pop. Per molti giovani (e non solo), il primo contatto con un evento religioso globale, a quanto pare, non passa più dai sacramenti, ma da un reel di 30 secondi o da una battuta virale. E questo, nel bene e nel male, cambia tutto.

In questo scenario, la Chiesa non è più solo un’istituzione millenaria, ma anche – volente o nolente – un soggetto narrativo all’interno dell’economia dell’attenzione. Il conclave, con il suo intrigo di silenzi, simboli, ritualità arcaiche e decisioni irrevocabili, è diventato materiale perfetto per la viralità.
La sacralità, in un certo senso, è stata “convertita” in contenuto. Ma non necessariamente svuotata. La figura del Papa non è diventata meno autorevole, ma più accessibile. La sua immagine, filtrata dai meme e dalle stories, entra oggi in spazi quotidiani e informali dove prima non sarebbe mai arrivata. Il paradosso è che proprio questa esposizione, spesso ironica, può accendere una nuova curiosità, anche spirituale, in un pubblico che era rimasto distante.
Il rischio, certo, è che tutto diventi superficie, che la fede si riduca a un contenuto sui social, e il conclave a talent show. Ma forse, in un mondo dove nulla comunica se non è condiviso, anche la Chiesa ha capito che restare invisibile è il modo più sicuro per scomparire. Papa Francesco è stato il primo a intuire questo: per restare rilevante la Chiesa doveva iniziare a parlare anche nei luoghi dove si costruisce l'immaginario collettivo. Così oggi anche il sacro entra nei linguaggi della rete. Non è necessariamente un segno di decadenza: può essere una nuova forma di prossimità. Certo, resta il rischio di ridurre tutto a spettacolo. Ma ignorare questi codici, per la Chiesa e per chi comunica, significa lasciare vuoti spazi ormai centrali.
La sfida è trovare un equilibrio tra profondità e visibilità. E forse, proprio lì, si gioca una nuova possibilità di incontro.